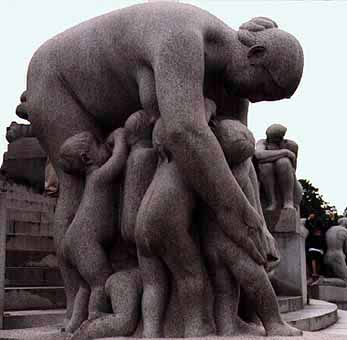"Quante divinità abbiamo creato.........le
abbiamo adorate, le abbiamo abbracciate, le abbiamo incoronate........
Ma il fatto più strano è che per tutto il tempo
in cui le stavamo adornando, noi sapevamo che avremmo voluto
frantumarle; è come se un piccolo essere dentro di noi
ce lo suggerisse". (Gustav Vigeland, 1897)
La cultura non solo visiva della Norvegia ha origini relativamente
recenti, e dalla preistoria fino al '300, anno di una famosa
pestilenza, si susseguono secoli di scarso significato culturale
e di scarse testimonianze archeologiche, fatta eccezione per
le stupende chiese in legno, le stavkirker della civiltà
vichinga, straordinario esempio di architettura medioevale.
Solo nel XV secolo nasce una letteratura "nazionale",
di cui sarà massimo rappresentante Ludvig Holberg, e
bisogna arrivare all'800 per trovare la "società
norvegese", che rappresenta il maggior movimento culturale
strutturato, in grado di risvegliare una coscienza nazionale
sostanzialmente non troppo reattiva.
Verrà l'opera di Edvard Munch, alla fine del secolo XIX,
ad attizzare il fuoco sotto le ceneri, a mettere in evidenza
e a "gridare" le angosce di una società in
crisi prossima ad una svolta epocale che sarà drammatica
e sofferta, come in tutto il resto dell'Europa.
Sulla base di queste premesse va letta l'arte norvegese del
primo '900 e l'opera di Gustav Vigeland (1869-1943).
Noto soprattutto come artefice del parco di Frogner a Oslo,
Vigeland ne curò l'impianto paesaggistico e l'arredo
urbano, realizzando entro il suo perimetro un ciclo scultoreo,
il "Ciclo della vita", che rimane il suo capolavoro
assoluto: disposti secondo un asse che seziona in due parti
l'intera area, sono presenti più di 200 gruppi scultorei,
sia in bronzo che in granito, lungo un percorso che si snoda
per circa 1 chilometro, un grandioso racconto monumentale iniziato
nel periodo tra le due guerre mondiali e concluso all'inizio
degli anni '50.
Il tema fondamentale presente nel Vigelandpark ed in tutta l'opera
del suo autore, espresso in un linguaggio formale di straordinaria
creatività, fortemente innovativo, è quello del
rapporto uomo-natura, un rapporto simbiotico che intreccia in
modo indissolubile corpi maschili e femminili e motivi vegetali,
uomini ed animali, che esprime innanzi tutto una mentalità
tipicamente nordica, nella quale la natura, concepita come madre
di ogni forma vivente, riassume in un rapporto olistico tutto
il mondo fenomenico.
E' la stessa componente naturalista-ambientalista che si rintraccia
nell'architettura organica di Alvar Aalto e Eero Saarinen, finlandesi,
nel pensiero del norvegese Christian Norberg-Schulz, teorico
e storico dell'architettura, dove ritroviamo ("Genius loci", 1979)
il concetto di una dimensione esistenziale dello spazio ambientale,
nell'opera architettonica di Knut Knutsen, autore di straordinarie
costruzioni armonicamente integrate nell'ambiente naturale,
nella storia della cultura scandinava, dove l'arte, come nel
Vigelandpark, è sempre rappresentazione e metafora degli
avvenimenti della vita, la caccia, la maternità, l'amore,
l'infanzia, il mondo animale e vegetale, confusi in una comune
epopea.
Denominatore comune che percorre tutta l'opera di Vigeland,
è una percezione della forma estremamente sensuale,
una morbida plasticità animata da una tensione costante
che dinamizza i volumi, ad esprimere un intrinseco conflitto
tra materia e idea, tra amore e morte, tra eroismo e tormento
esistenziale, ed anche tra uomo e donna, tra sesso maschile
e femminile, simbolo del disfacimento delle istituzioni tradizionali,
la famiglia per prima.
E', quest'ultimo, un tema ricorrente nel periodo storico di
fine secolo, soprattutto nell'ambiente mitteleuropeo dove
un clima di rassicurante e decadente estetismo viene gradualmente
sgretolato da inquietudini sempre più manifeste, basti
pensare a Klimt, a Schiele, a Kokoschka, alla confluttialità
latente delle figure intrecciate nel "Il bacio",
al drammatico dinamismo espressionista di Auguste Rodin, con
il quale Vigeland ebbe rapporti a Parigi.
Tuttavia, pur venato dal pathos esistenzialista di matrice
kirkegaardiana, dall'angoscia di vivere che nell'opera del
conterraneo Edvard Munch esplode con incontenibile soggettività,
il linguaggio di Vilegand si differenzia per un'impronta epica
di ampio respiro, resa in una soluzione formale realistica
e composta, dal significato simbolico, ad esprimere una introspezione
sofferta ma controllata, lontana dalla tendenza autodistruttiva
di Munch, alleggerita dall'"eros" che, più
o meno esplicitamente, percorre tutta l'opera di Vigeland.
Altrettanto incisivo è il linguaggio grafico di Vigeland,
nei piccoli schizzi preparatori a china nera, fortemente contrastati,
dal vigoroso tratteggio, scarni ed essenziali nella definizione
di volumi netti attraverso un gioco chiaroscurale sapiente
e sicuro.
Testamento spirituale di Vigeland, che nell'ultima parte
della sua esistenza lavorò quasi esclusivamente al
parco di Frogner, può considerarsi il Monolito di granito,
alto 17 metri, che riassume la storia della vita umana nel
groviglio di 121 figure contorte in un movimento ascensionale
a piramide, circondate al perimetro da 36 statue, probabilmente
il monumento in granito più alto del mondo, certamente
il più suggestivo inno alla vita, alla natura e all'amore.
|